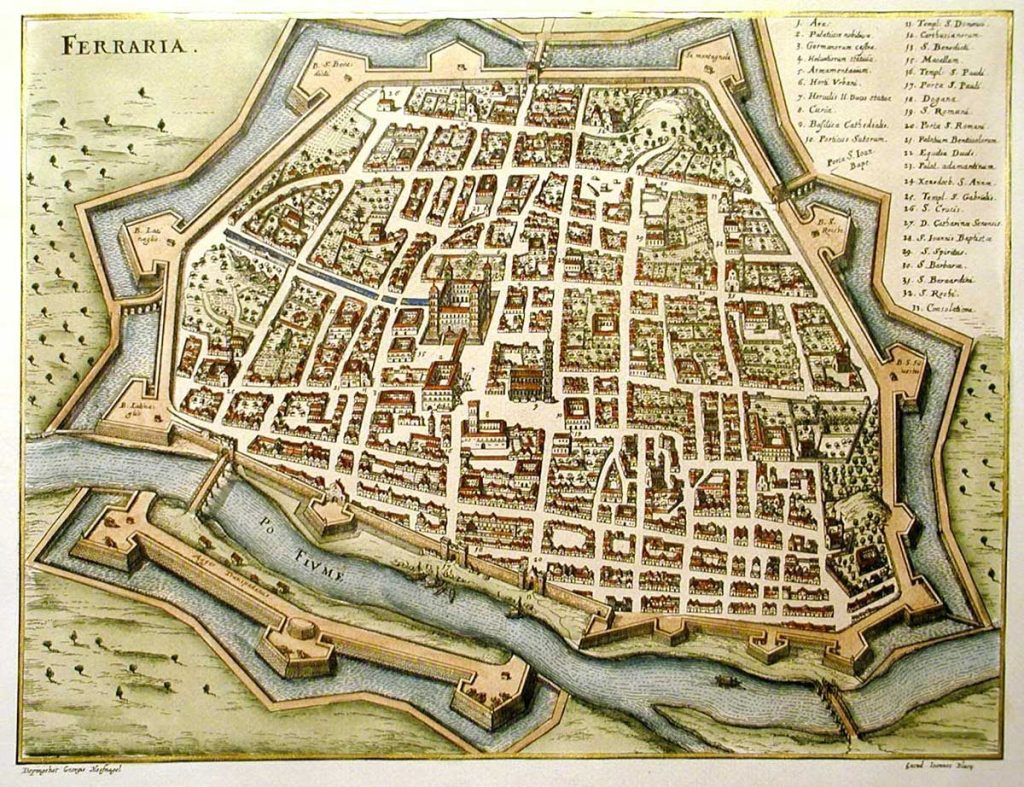
A proposito di Ferrara, Enea Silvio Piccolomini, lasciata Bologna, prosegue il suo viaggio sul Reno e sul Po fino a raggiungere la città di cui traccia la storia nei Commentarii. Tra le figure che spiccano nelle vicende ferraresi emerge Matilde di Canossa, presentata dall’autore come comtissa Mathildis, fama excellens foemina.

Donizone, monaco benedettino, poeta e cronista, è il primo a scrivere una biografia su Matilde di Canossa; è sorprende l’interesse e l’ammirazione che una donna laica suscita in figure quali un monaco e un papa, tanto da spingerli a scrivere di lei. Nella miniatura, Donizone presenta alla contessa il poema in esametri leoniani Vita Mathildis; il biografo la prega di accettare il codice, come viene scritto sotto l’immagine: O splendida Matilde, ti prego accetta cara questo volume.
Mathildis lucens precor hoc cape carvo volumen.
Nei Commentarii Piccolomini si sposta a Mantova e qui torna a parlare di Matilde che era stata signora della città, ponendo l’accento sul rispetto e sull’ammirazione che suscita Mathildis gloriosa mulier, per utilizzare le parole del pontefice, anche secoli dopo la sua morte, avvenuta nel 1115. Nonostante il lascito di eredità dei suoi domini alla Chiesa, alla morte della donna, la stabilità del governo iniziò a vacillare alternandosi tra imperatori e pontefici, fino al dominio dei Gonzaga.
Matilde nacque nel 1046, figlia di Bonifacio, marchese di Toscana, e della contessa Beatrice di Lotaringia; dopo la morte del padre e dei fratelli maggiori, ereditò vasti domini. Si sposò due volte, ma entrambe furono fallimentari. In prime nozze si unì a Goffredo di Lorena, però il matrimonio fallì, anche sul piano politico: mentre Goffredo si alleava al partito imperiale, la casa di Canossa era per tradizione la principale collaboratrice della politica papale e Matilde divenne una fervente sostenitrice del papato durante la lotta per le investiture. Nel 1089, Matilde sposò Guelfo V di Baviera, un’alleanza politica volta a rafforzare la posizione papale contro l’Impero. Tuttavia, il matrimonio fu annullato pochi anni dopo e Matilde continuò a governare da sola i suoi vasti territori, mantenendo una posizione di rilievo nella sfera politica.
La sua alleanza con Papa Gregorio VII fu determinante, soprattutto durante l’episodio dell’umiliazione di Canossa nel 1077, quando l’imperatore Enrico IV si recò al castello di Matilde per chiedere il perdono papale. Questo evento simboleggia la supremazia del potere spirituale su quello temporale.
In Vita Mathildis di Donizone è raffigurato Enrico IV in ginocchio che invoca l’abate di Cluny e Matilde per ottenere l’assoluzione dalla scomunica, la scritta sotto l’immagine recita: Il re prega l’abbate e supplica anche Matilde.

Piccolomini ricorda la capacità della contessa, durante l’assedio di Ferrara del 1101, di togliere le armi ad Enrico IV per riconsegnarle alla Chiesa; Enea citando tale evento confonde però Enrico IV con Enrico III.
Rex rogat abbatem Mathildam supplicat atque.
Nei Commentarii è tracciata un’immagine esemplare di Matilde di Canossa per tramandare la memoria di un modello positivo di femminilità; Pio ricorda ed elogia la sua indipendenza e il suo ruolo di guida in un’epoca di conflitti tra autorità laica e religiosa. La sua figura è emblematica nella storia poiché simbolo di devozione religiosa e abilità politica, capace di governare nonostante, essendo donna, le si prospettino maggiori difficoltà.

PICCOLOMINI, Commentarii: Libro II, cap. XXXIX, XLIII.
