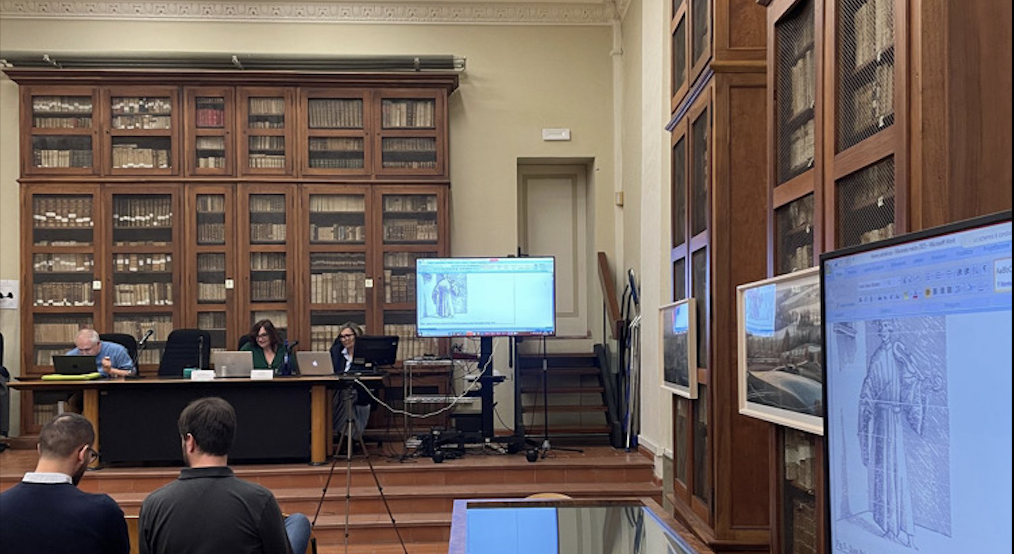Ospiti del secondo e del terzo incontro del IX ciclo di seminari sull’Umanesimo Adriatico sono stati la Prof.ssa Snežana Milinković (Università di Belgrado) e il Prof. Guido Bartolucci (Università di Bologna).
Nel primo intervento, tenutosi il 25 marzo, dal titolo Homo adriaticus. Zuan Polo Liompardi e la sua opera schiavonesca, la relatrice ha presentato la figura di Giovan Polo Liompardi, buffone e verseggiatore veneziano attivo nella prima metà del Cinquecento. Le poche informazioni biografiche certe derivano soprattutto dalle testimonianze dei contemporanei, passate in rassegna. Alessandro Caravia nel suo poemetto in ottave Il sogno (1541) annotava l’età della morte dell’amico; lo ricordano anche Pietro Aretino, nella lettera indirizzata al Caravia il 12 marzo 1542 e nella prima giornata dei Ragionamenti, così come Marin Sanudo nei suoi Diarii.
‘Operatore culturale’ e intrattenitore aderente a una cultura mista, gli apparteneva un plurilinguismo esistenziale, quotidiano e mimetico, essendo immerso in un contesto storico «che si nutriva di ciò che rappresentava al meglio la diversità e l’unità, allo stesso tempo, delle contraddizioni e delle sovrapposizioni culturali». Si inserisce in quella che Manlio Cortelazzo ha definito “letteratura schiavonesca”, costituita da opere in cui la lingua è il veneziano-pavano-fiorentino, con apporti lessicali e morfologici slavi.
Il suo libro in ottava rima, intitolato Libero del Rado stixuzo (Venezia, Bernardino Vitali, 1533), dimostra come il ruolo di schiavone di Zuan Polo corrispondesse a una maschera, e rivela la natura del gioco plurilingue-letterario. Dall’analisi del proemio, emergono numerosi richiami parodistici a Boiardo e Ariosto e parecchie contraddizioni relative al protagonista, che coincide con l’autore-attore. Esso diventa il vero argomento dell’opera, mentre il libro si fa ulteriore mezzo per esaltare la voce e la performance dell’autore.
Nel secondo intervento, tenutosi martedì 1 aprile, dal titolo Da Galateo a Galatino: la tradizione ebraica e l’umanesimo adriatico, il relatore ha esposto e analizzato la ricezione della tradizione ebraica nel mondo adriatico, passando in rassegna gli autori e le opere più significativi. A partire dal 1492, anno in cui gli ebrei vengono espulsi dalla Spagna, trovando rifugio in città come Salonicco, Venezia, Ancona, Ragusa, si assiste a una trasformazione dello spazio adriatico, che vede muoversi gli ebrei sefarditi. Con la circolazione di idee, manoscritti e informazioni, cambia il modo in cui i cristiani guardano all’ebraismo. In seguito alla riscoperta dei testi apologetici della patristica greca, come Eusebio di Cesarea (Praeparatio evangelica), gli umanisti iniziano a utilizzare il modello patristico per legittimare l’uso della tradizione classica davanti alle critiche della Chiesa, che vedeva l’Umanesimo come paganeggiante. Nello stesso periodo, hanno una nuova circolazione diversi trattati antigiudaici (di Porchetus de Salvaticis, Paolo di Burgos) che discendono dal Pugio Fidei (1265) di Raimondo Martini, in cui l’autore scrive come sia necessario, per convincere gli ebrei della verità della religione cristiana, studiare i loro testi, nei quali sono spiegati i principi del cristianesimo.
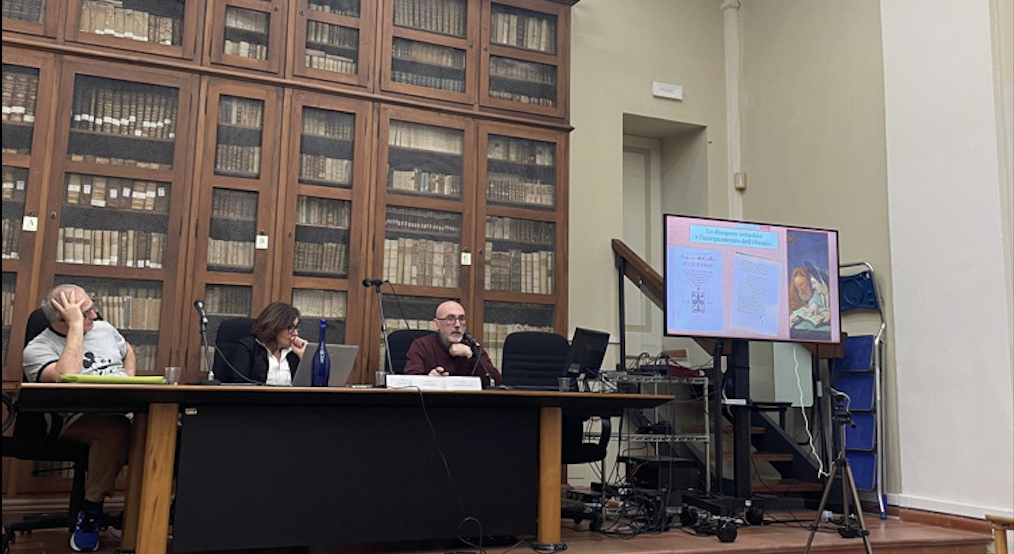
Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola intercettando questa letteratura. Il primo, che ha accesso a numerose e variegate fonti, come quelle islamiche, nel De Christiana religione riutilizza il modello patristico per formulare una nuova riflessione sulla religione cristiana. Il secondo, che imita lo schema fiorentino-ficiniano, adotta soprattutto testi cabalistici tradotti da Flavio Mitridate per comporre le novecento Conclusiones, dove cerca di conciliare le diverse tradizioni e religioni. Di Antonio De Ferraris detto il Galateo è stata invece ricordata la lettera De neofitis, indirizzata all’amico Belisario Acquaviva, il cui figlio stava sposando una donna proveniente da una famiglia di ebrei convertiti. L’epistola è una grande opportunità di riflessione sul ruolo che i neofiti hanno all’interno della società napoletana. Pietro Galatino poi, che studia l’ebraico, nel suo De Arcanis (1518), dove intende presentare i segreti della verità del cristianesimo, attinge a numerose fonti cabalistiche, talmudiche e polemiche contro gli ebrei. Francesco Zorzi utilizza invece la tradizione ebraica per arrivare a un tipo di cristianesimo spiritualizzato. Tra gli intellettuali ebrei dello spazio adriatico, infine, sono stati menzionati il tipografo Girolamo Soncino e Isaac Abravanel.
Grazie a tutte e a tutti per la partecipazione e appuntamento al 6 maggio.