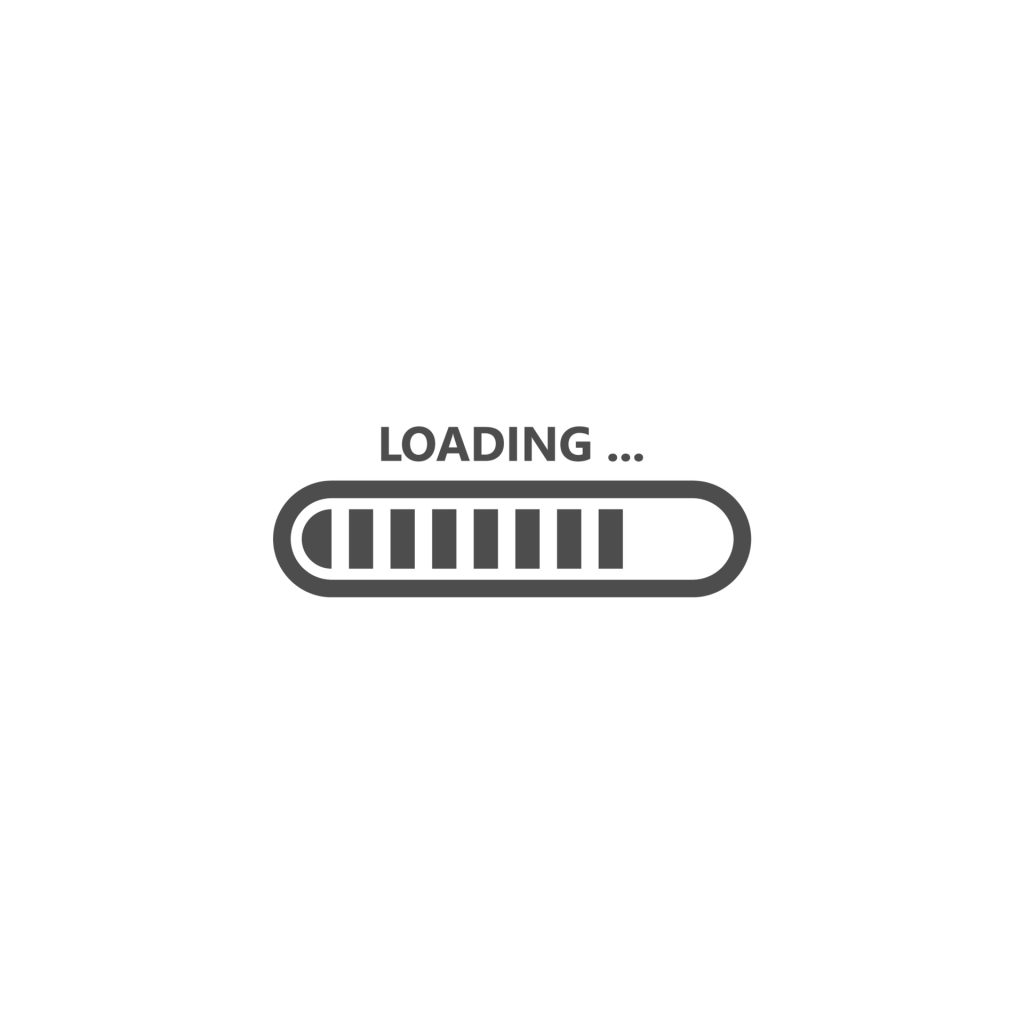Francesco Filelfo e non solo

Sulla figura di Francesco Filelfo le ricerche proseguono sugli aspetti linguistici della sua produzione, sul sistema delle sue relazioni, sulle implicazioni storico-artistiche. Un campo di indagine preso in considerazione è quello del rapporto con la tradizione medica e la funzione ricoperta nell’ambito dello sviluppo del genere satirico.